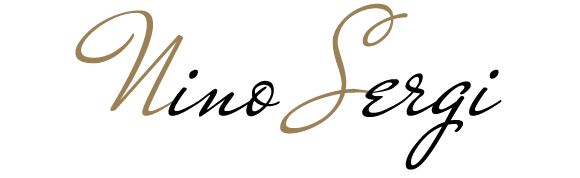La Global Sumud Flotilla, con le sue decine di imbarcazioni e centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo, è molto più di una missione umanitaria. È, prima di tutto, un atto politico e morale. Nella sua ostinata determinazione a raggiungere Gaza nonostante rischi e minacce, denuncia con forza ciò che da mesi molti governi fingono di non vedere: la loro colpevole inerzia davanti a crimini che calpestano il diritto internazionale e offendono i valori fondamentali dell’umanità. Di fronte alla tragedia che si consuma nella Striscia, la comunità internazionale ha infatti scelto di non agire o di farlo in modo simbolico e comunque tardivo.
La Flotilla cerca di raggiungere Gaza non soltanto per consegnare aiuti materiali, cibo, medicinali, beni essenziali, ma soprattutto per dire al mondo che non possiamo voltare lo sguardo altrove. La sua presenza è un atto di testimonianza e di solidarietà concreta; è la dichiarazione collettiva di “esserci”, accanto a una popolazione trattata peggio degli animali, privata di ogni diritto e dignità. “Noi ci siamo”: questo messaggio politico e umano potente attraversa il Mediterraneo e raggiunge i cuori prima ancora delle coste.
L’orrore dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, condannato severamente da tutti e che aveva suscitato profonda solidarietà con Israele, non può in alcun modo giustificare la risposta che ne è seguita. Non è stata difesa, è stata punizione collettiva: oltre ventimila bambini uccisi, molti dei quali definiti con cinismo “futuri terroristi”, migliaia di persone mutilate, traumatizzate, condannate a un’esistenza di miseria e dolore, con la spinta ad andarsene altrove. Gaza è stata trasformata in un campo di rovine e disperazione, e tutto questo sta accadendo nel silenzio o nell’indifferenza delle istituzioni internazionali. L’indignazione non è più un’opzione: è un dovere. La Flotilla, in questo contesto, assume un significato molto forte: un atto di responsabilità collettiva e anche di disobbedienza civile contro l’indifferenza.
Questa scelta di protesta sentita come dovere mi riporta ad un’altra stagione del pacifismo italiano ed europeo, attraversata da esperienze simili, in cui la società civile ha deciso di non restare spettatrice. Il 3 ottobre ricorre l’anniversario della morte di Moreno Locatelli, pacifista dei Beati Costruttori di Pace, ucciso a Sarajevo nel 1993 mentre, attraversando un ponte, portava all’altra parte un messaggio di riconciliazione in piena guerra civile. La sua morte aprì una profonda riflessione sulle forme dell’azione nonviolenta e sull’esigenza di coniugare il coraggio con la prudenza, la passione morale con l’analisi attenta dei contesti e delle conseguenze.
Una riflessione che si riferiva anche al pensiero di Alexander Langer, per il quale la pace non è un gesto episodico o un atto simbolico, ma un processo lungo e faticoso, fatto di mediazione, ascolto, piccoli passi. Costruire ponti dove altri innalzano muri, accettare la lentezza e l’incompiutezza come parte dell’azione politica, comprendere la complessità delle situazioni senza rinunciare a trasformarle: questa era la sua idea di pacifismo, ed è la lezione che oggi torna urgente. A chi lo accusava di ingenuità, Langer rispondeva che la mediazione non è debolezza, ma la forma più esigente di impegno politico e umano.
Ricordo poi quanto avvenuto alla Freedom Flotilla per Gaza il 31 maggio 2010, anch’essa con l’obiettivo di portare aiuti, forzando il blocco ritenuto illegittimo, e di sollevare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla condizione degli abitanti di Gaza. Le navi battevano bandiere americana, turca, greca e svedese con a bordo 610 persone fra cui 44 tra parlamentari e politici, il premio Nobel per la pace Mairead Corrigan e lo scrittore svedese Henning Mankell. Alle richieste israeliane, in acque internazionali, la risposta del comandante della Mavi Marmara, la nave più grande, fu: “Negativo, negativo. La nostra destinazione è Gaza, la nostra destinazione è Gaza.” Il risultato fu l’uccisione di nove attivisti.
Le operazioni umanitarie delle Ong degli ultimi decenni hanno confermato questa necessità: occorre osare sempre e molto, ma nello stesso tempo valutare attentamente i rischi, conoscere a fondo le dinamiche dei conflitti, evitare azioni che, pur animate da nobili intenzioni, possano rivelarsi inefficaci o persino controproducenti. Non si tratta di rinunciare alla forza dell’azione civile di aiuto e di presenza umanitaria e solidale, ma di renderla più consapevole, incisiva, coerente con gli obiettivi che si vogliono raggiungere.
La Flotilla rappresenta oggi un esempio concreto di queste esigenze. Non solo sta portando l’attenzione mondiale sui crimini commessi contro i civili di Gaza, ma sta anche contribuito a rimettere il tema palestinese al centro del dibattito pubblico e politico, costringendo governi e istituzioni a posizioni meno ambigue. Il sostegno che arriva dalle piazze europee e dalle richieste di centinaia di migliaia di persone, le prese di posizione di organizzazioni e parlamenti, l’invio ora di navi di assistenza da parte dei governi di Italia e Spagna sono tutti segnali di un cambiamento, tardivo ma possibile, reso concreto dall’azione collettiva e nonviolenta. Perfino governi che continuano a considerare Israele un alleato strategico e non osano sono stati costretti a reagire, a esporsi, a prendere posizione.
Ora, però, la missione entra in una fase nuova e più rischiosa. L’avvicinamento alle acque territoriali di Gaza moltiplica le incognite e impone un’attenzione ancora maggiore. Continuare è necessario, ma lo è anche farlo con lucidità, e con le doverose mediazioni, per non ripetere errori del passato e per mantenere la forza e la credibilità dell’iniziativa. Lo sottolinea anche il capo delle Stato, Sergio Mattarella, che invita a cogliere le occasioni di mediazione. Le ingenuità, per quanto animate dalle migliori intenzioni, potrebbero compromettere l’obiettivo stesso della Flotilla e la sua denuncia dell’ingiustizia che ha assunto le forme della criminalità, per restituire centralità alla dignità umana.
In fondo, questa è la sfida del pacifismo del nostro tempo: denunciare e, al tempo stesso, costruire le condizioni perché la guerra diventi impensabile, nonostante ogni evidenza contraria; non solo soccorrere le vittime, ma cambiare le logiche che le producono; non solo indignarsi per l’ingiustizia, ma agire per sradicarla. Agendo senza tregua, in modo puntuale ma con i tempi e nei modi che si dimostrano più percorribili e utili.
La Flotilla, nel suo navigare controvento, ci ricorda che la pace non è un dono che arriva dall’alto, ma il frutto di un impegno collettivo, quotidiano, ostinato. Come le centinaia di manifestazioni sempre più diffuse nelle molte piazze d’Europa e di tutto l’Occidente, anche la Flotilla ci ricorda che quando i governi tacciono la società civile può e deve farsi voce della giustizia. È questo, oggi, il compito più alto: tenere viva l’idea che nessun popolo, nessun bambino, nessun essere umano può essere sacrificato sull’altare della vendetta o dell’indifferenza. La rotta tracciata dalla Flotilla non riguarda solo Gaza: riguarda tutti noi, e il futuro stesso dell’umanità che vogliamo costruire.
Pubblicato su: VITA