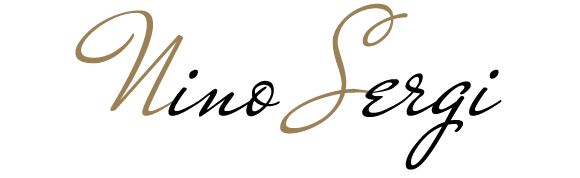“Non più stranieri, non ancora italiani. Cittadini sospesi – Le nuove generazioni con origini transnazionali”. Intervista sul mio saggio pubblicato dal Gruppo Albatros, ottobre 2025.
Perché riconoscere la cittadinanza non è un “favore”, ma un investimento sul futuro dell’Italia
Nino Sergi, presidente emerito dell’organizzazione umanitaria Intersos, pubblica “Non più stranieri, non ancora italiani. Cittadini sospesi. Le nuove generazioni con origini transnazionali” dove affronta una delle questioni decisive del nostro tempo: la riforma della cittadinanza italiana. «Nel nostro Paese», dice, «vivono ormai oltre un milione di ragazze e ragazzi nati da genitori stranieri. Parlano italiano, studiano nelle nostre scuole, condividono sogni e valori con i coetanei italiani, ma restano giuridicamente esclusi da una piena appartenenza sociale e politica. Perché? L’Italia sta perdendo un’occasione»
di Anna Spena
Mentre la politica italiana è ferma all’inizio degli anni Novanta, la realtà è andata avanti. Nel suo nuovo saggio “Non più stranieri, non ancora italiani. Cittadini sospesi. Le nuove generazioni con origini transnazionali” (Albatros), Nino Sergi, fondatore e presidente emerito dell’organizzazione umanitaria Intersos, affronta una delle questioni decisive del nostro tempo: la riforma della cittadinanza italiana. La normativa, che ha infatti come riferimento gli anni Novanta del secolo scorso (legge 91 del 1992), non poteva prevedere i grandi cambiamenti in atto in Italia, in Europa e nel mondo. «Parlano italiano, studiano nelle nostre scuole, condividono sogni e valori con i coetanei italiani, ma restano giuridicamente esclusi da una piena appartenenza sociale e politica. Sono i figli e le figlie di genitori stranieri, nati o cresciuti in Italia: “cittadini sospesi” tra appartenenza reale e riconoscimento formale», dice Sergi. Nel nostro Paese vivono ormai oltre un milione di ragazze e ragazzi nati da genitori stranieri. Nel libro Sergi sviluppa una riflessione fondata su dati ufficiali, studi e analisi.

Perché è controproducente per l’Italia non riconoscere questo milione di persone?
Secondo l’Istat, tra 50 anni avremo 13 milioni di persone in meno. Lo ripeto: 13 milioni. Da 59 milioni del 2023 si passerebbe a 54,8 milioni nel 2050 e a 46,1 milioni nel 2080. Ci rendiamo conto del valore di questi dati? A questa riduzione si accompagna un progressivo invecchiamento della popolazione, un significativo aumento della speranza di vita e una crescente divaricazione tra la popolazione in età lavorativa e il resto dei residenti. Il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non lavorativa (0-14 e oltre i 65 anni) passerà da tre a due nel 2023 a circa uno a uno nel 2050, con un significativo aumento degli ultraottantenni e una conseguente riduzione della ricchezza nazionale. Ma c’è oltre un milione di persone che vuole essere italiano, che chiede di essere italiano, che ha conquistato già “l’essere italiano”. Perché l’Italia li rifiuta? Siamo pazzi? Visto che lo chiedono, rispondiamo. Visto che lo desiderano, approfittiamo. L’Italia sta perdendo occasioni. Sottolineo anche che mentre 6,1 milioni di italiani vivono all’estero, molti dei quali mai stati in Italia, i giovani nati e cresciuti qui restano esclusi. Un recente decreto-legge del 2025 ha ridotto gli automatismi dello ius sanguinis, ma la contraddizione resta aperta: si riconosce la cittadinanza (per discendenza di sangue) a chi non conosce il Paese e la si nega a chi lo abita ogni giorno.
Il libro mette insieme, in modo semplice e chiaro, molti dati. Perché e per chi l’ha scritto?
Il referendum sulla cittadinanza, che mirava a ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale necessario per l’acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri extracomunitari maggiorenni, estendendola automaticamente ai figli minorenni, non ha raggiunto il quorum. Temevo che l’insuccesso del voto potesse mettere una pietra tombale, almeno per alcuni anni, su una questione profondamente giusta e vantaggiosa, dati i tempi e la realtà italiana, e profondamente sentita dalle nuove generazioni transnazionali. Sono figli e figlie di una migrazione che ha riguardato solo i loro genitori o i loro nonni, ma che essi non hanno mai vissuto o non ricordano, perché nati o comunque cresciuti in Italia e perché si sentono e sono in realtà pienamente italiani. Ed è un rischio che l’Italia non può permettersi. Questo piccolo volume è stato un modo per reagire. E non a caso è dedicato “Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai membri del Parlamento, con il rispettoso invito a vivere e comprendere pienamente, al di là degli schieramenti, le sfide del nostro tempo, riconoscendo in ogni persona un individuo unico, degno di ascolto e di considerazione”, come si legge alla prima pagina. L’auspicio è che si possa aprire un confronto serio e rispettoso, ascoltando senza pregiudizi le diverse posizioni politiche e, soprattutto, la voce di questi nuovi italiani, nella consapevolezza che il fatto migratorio, nella sua complessità, non può restare materia di scontro, poiché riguarda il futuro dell’Italia e dell’Europa. Sono abbastanza fiducioso, perché è un tema su cui non ci sono più ragioni per non intervenire. Qualcuno potrebbe obiettare: “Non possiamo dare la cittadinanza a 12 anni.” Benissimo, riflettiamo: forse 14, forse 16. Ma perché dobbiamo aspettare i 18 anni?
Qual è il valore aggiunto che l’Italia potrebbe sperimentare rispetto a questo riconoscimento?
Avremmo dei cittadini in più, e cittadini convinti. A volte – e questa è una semplificazione eccessiva – i nostri giovani non vanno oltre il semplice dato di fatto di “essere italiani”. Per questi ragazzi e per queste ragazze, invece, essere italiani è stato un vero e proprio percorso di convinzione, perché a un certo punto hanno avuto la sorpresa di scoprire di non esserlo. Molti pensavano fin dall’infanzia: “Sono italiano come gli altri, vado a scuola con gli altri.” Poi, a un certo momento, magari per la necessità di un documento o di un permesso per l’iscrizione scolastica, da ragazzini scoprono di non essere italiani. Da quel momento in poi, tutto diventa una salita e ci si convince sempre di più di essere italiani. È una scoperta che fanno e che diventa un convincimento che, talvolta, è un senso di italianità molto superiore a quello dei nostri figli. Perciò, avremmo cittadini molto più convinti di noi, perché l’hanno voluto, l’hanno cercato. Insomma, negare loro un riconoscimento formale della cittadinanza, nel momento stesso del loro percorso di maturazione umana e consapevolezza politica, significa ignorare il loro vissuto, con il rischio di compromettere il senso di appartenenza e la fiducia nelle istituzioni. Gran parte non ha mai vissuto in un altro Paese, se non nella memoria trasmessa dai genitori o dai nonni. Tenerli ai margini significa rinunciare a una componente vitale della nostra società.
In Italia c’è anche un problema di linguaggio
È sciocco chiedere a un ragazzo nato qui: “Tu da dove vieni?”. Dobbiamo abituarci a un nuovo linguaggio in Italia. Lui viene da Gallarate, è nato a Gallarate, si sente italiano, non viene dall’Africa. Perciò, dobbiamo fare attenzione a porre domande come quella citata sopra. Perché la prospettiva è diversa oggi: lui si sente italiano. L’immigrazione è stata la storia dei suoi genitori o dei suoi nonni, non è la sua storia. Perciò, anche noi dobbiamo abituarci a un linguaggio diverso. Spero che ci si riesca gradualmente. È un fatto culturale, richiede tempo e soprattutto convinzione dell’importanza di questo cambiamento. La scuola, dove negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero di studenti di origine straniera, in questo, è fondamentale. Oltre 914mila alunni, l’11,2% del totale, non hanno la cittadinanza italiana; il 65% di loro è nato in Italia. La scuola è il luogo decisivo dell’integrazione, dove si costruisce ogni giorno un nuovo senso di appartenenza, ma deve essere supportata da politiche pubbliche che garantiscano l’accesso all’istruzione, alle attività formative e agli spazi di socialità anche per i più fragili. Il cambiamento deve partire dalla scuola e dal cambiamento di atteggiamento dei media e della politica. Se continuano a considerarli sempre come “l’immigrato”, è sempre immigrato, anche se quel ragazzo è ormai la terza generazione in Italia. È evidente che non funziona più. Ormai anche un bambino adottato, se ha la pelle nera, è considerato un immigrato. Perciò, dobbiamo davvero acquisire una mentalità nuova. L’Italia è cambiata e dobbiamo prenderne atto.
Quanta distanza c’è tra questa realtà e la narrazione pubblica?
La narrazione pubblica è ancora segnata da paure e stereotipi. Ma dobbiamo aprire gli occhi di fronte alla mutata realtà italiana e alla sua “mutazione morfologica” (come l’ha definita il Censis), riconoscendo che la pluralità culturale non è una minaccia ma una risorsa da valorizzare, parte integrante dell’identità nazionale. Una parte del discorso politico, invece, alimenta consapevolmente percezioni distorte, creando diffidenza. Abbiamo bisogno di una visione razionale, informata e di lungo periodo, basata su dati e su principi di uguaglianza: riconoscere la migrazione come fenomeno strutturale delle società contemporanee; promuovere parità di diritti e doveri; favorire la partecipazione civica dei nuovi cittadini. La sfida è dunque culturale e politica insieme. È proprio la capacità di governare il cambiamento, incluso quello prodotto dalla mobilità umana che da secoli caratterizza le società, che può permettere ai nostri valori, alle nostre tradizioni e ai nostri stili di vita di essere non solo trasmessi e condivisi, ma anche arricchiti dall’incontro con altri valori e modi di vivere, ispirati alla consapevolezza costituzionale di diritti e doveri condivisi.
L’immigrazione non è un’emergenza
No, non lo è. Ma è ma un fatto strutturale, che può rappresentare una risorsa importante. Nel 2025, per esempio, gli occupati stranieri sono 2,37 milioni (10,1% della forza lavoro), generano 164 miliardi di euro, pari all’8,8% del Pil, e coprono ruoli chiave in agricoltura, edilizia e ristorazione. Le previsioni per il 2028 dei settori produttivi parlano di 3 milioni di nuovi lavoratori richiesti, di cui 640mila saranno inevitabilmente immigrati. Un dato spesso trascurato è l’emigrazione dei giovani stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, che negli ultimi anni ha rappresentato un terzo dei 175mila italiani emigrati mediamente ogni anno. Il 38,4% dei giovani stranieri tra gli 11 e i 19 anni residenti in Italia immagina il proprio futuro all’estero, contro il 34% dei coetanei italiani. Circa l’8% vorrebbe vivere nel Paese d’origine, mentre oltre il 30% si proietta verso un altro Paese, diverso sia dall’Italia che da quello di origine. Solo il 37,9% desidera restare in Italia. Altro che “sostituzione etnica”. L’Italia, dopo aver investito in formazione, subisce passivamente perdita di capitale umano, minore natalità, indebolimento produttivo. “Quando cresci in un Paese che non investe mai su di te l’unica cosa che hai voglia di fare è scappare”, è la testimonianza di molti.