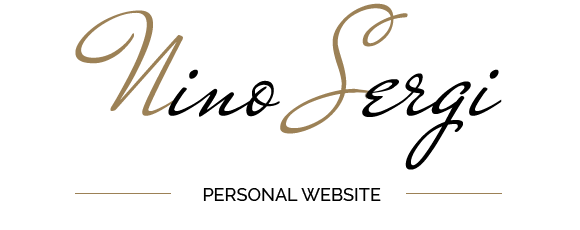Intervista per “TOMORROWLAND. Una strategia per la nuova cooperazione italiana”. A cura di Emilio Ciarlo, Ebook, Edizioni Palinsesto, Settembre 2015.
Capitolo 4 – Nino Sergi. Vogliamo continuare a cambiare il mondo. Lo sguardo della società civile e delle Ong.
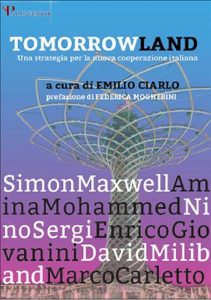
Tu sei la memoria storica e sei stato un po’ l’anima della cooperazione italiana nata attorno alla vecchia legge 49. Ci puoi ricordare il contesto in cui nacque, i suoi maggiori pregi e i suoi limiti?
Si tratta di un passato ormai lontano, ma la domanda è opportuna. Sono stati anni di ampio dibattito e approfondimento, su posizioni spesso divergenti e con un coinvolgimento non solo degli addetti ai lavori: sulla fame nel mondo, la valorizzazione delle risorse locali, i modelli di sviluppo e di cooperazione incentrati sui bisogni dell’essere umano e sull’auto-sviluppo, i settori prioritari, la bilateralità o multilateralità abbinate all’esigenza di un sempre maggiore impegno e protagonismo dell’Italia, la struttura amministrativa preposta all’attuazione delle politiche eccetera. Alcuni dei temi centrali della legge 125/2014 erano stati dibattuti già in quegli anni.
E’ con la legge 38 del 1979 che l’Italia avvia una vera politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, con un’architettura che comprende un comitato interministeriale di indirizzo politico, un comitato consultivo, uno specifico Dipartimento dotato di ampia autonomia e di ‘contabilità fuori bilancio’ all’interno degli Esteri. Gli stanziamenti sono raddoppiati di anno in anno, fino a superare nel 1986 la media dei Paesi Dac, partendo da un misero 0,08% del Pil nel 1979, con l’ambizione di raggiungere lo 0,7% nel 1990.
A metà degli anni ’80 ben due leggi, contemporanee e parallele, hanno regolato la cooperazione allo sviluppo. Alla legge 38 è stata affiancata la 73 nel 1985. Essa ha istituito il Fai, Fondo aiuti italiani, dotato di 1.900 miliardi di lire, con lo scopo di assicurare in un periodo di 18 mesi “la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione, dal sottosviluppo”. E’ stata la risposta ad una meritoria pressione politica del partito radicale che chiedeva di agire in fretta in seguito alla mortale siccità del Sahel. La doppia gestione ha dimostrato presto i suoi limiti e le sue contraddizioni, tanto che prima della fine dei 18 mesi molte erano le proposte di legge depositate in Parlamento e unanime è stata la volontà di una riforma legislativa organica sull’intera materia.
Nel 1987 è stata quindi approvata la legge 49. Un’innovativa e buona legge, che riunificava il Dipartimento e il Servizio speciale per gli interventi straordinari del FAI in un’unica strategia complessiva di intervento, definita e attuata dal Mae tramite la Dgcs, direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Al Cics, comitato interministeriale, competeva la definizione delle politiche e la programmazione, al comitato direzionale l’approvazione delle iniziative, al comitato consultivo, suddiviso subito in quattro gruppi di lavoro, il contributo di idee dei vari soggetti della cooperazione. Peccato che la legge non sia stata gestita in stretta adesione alle sue finalità e alle procedure di gestione e valutazione che erano state decretate, come è poi risultato dalle indagini degli anni ’90. Prima di parlarne, torno indietro sull’andamento dell’impegno finanziario dell’Italia in quegli anni, perché rimane esemplare e dovrebbe spingere il nostro governo a fare altrettanto oggi, date le interconnessioni evidenti che si sviluppano tra i nostri paesi europei e quelli più poveri, in situazione di conflitto, di negazione dei diritti umani, con dinamiche demografiche accelerate, con pochi sbocchi lavorativi, con le nuove generazioni alla ricerca di un futuro migliore. Stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo pari allo 0,16% del PIL, come nel 2014, dimostrano purtroppo la demagogia e l’inganno delle dichiarazioni politiche che nel nostro paese da anni ripetono che occorre “aiutarli a casa loro” e rafforzare la cooperazione allo sviluppo. Nell’84 si era già allo 0,34%, poco sotto la media Dac, superandola nel 1986 con lo stanziamento pari allo 0,4% del Pil che collocava l’Italia al quinto posto tra i principali paesi donatori. Si è mantenuta su simili livelli nell’87 (0,35%), nell’88 (0,39%) con un crescente ampliamento della cooperazione bilaterale, nell’89 (0,42%, il massimo mai raggiunto), per poi ridiscendere allo 0,32% nel 1990, allo 0,30 nel 91 e allo 0,32 nel 92 rimanendo comunque l’Italia nei primi posti tra i grandi donatori mondiali.
Come ricordi quindi gli anni ‘90, anni di grandi scandali. Cosa hanno lasciato e quanto hanno inciso negativamente nella timidezza del periodo successivo?
Il 1992 è stato per la cooperazione italiana l’anno dell’avvio a tappeto delle indagini della magistratura e della procura generale presso la Corte dei conti per presunte irregolarità, con un’inevitabile irrigidimento degli organi di controllo e un gravoso impegno lavorativo per rispondere ai rilievi. Ciò ha comportato un forte rallentamento della pianificazione strategica e delle attività, che si è prolungato nel 1993 e negli anni successivi. La legge 412/91, che ha generalizzato l’obbligo di ricorrere alle gare per l’affidamento dell’esecuzione dei progetti di cooperazione, ha trovato impreparata la Dgcs che, pur con una dotazione di 550 persone, non è stata in grado di attuarne le norme con competenza. All’origine delle deviazioni e inefficienze della cooperazione italiana c’erano in particolare la scarsa capacità propositiva, la mancanza di programmazioni strategiche per paese, l’utilizzo improprio del canale degli aiuti straordinari, il mancato ricorso alle gare d’appalto, la carenza di personale amministrativo e contabile qualificato, l’insufficienza delle attività di valutazione e monitoraggio, procedure incerte, lente e macchinose, in particolare per l’erogazione dei prestiti, competenze e responsabilità mal definite.
Su pressione del Parlamento, con la legge finanziaria 1993 i fondi per la cooperazione allo sviluppo sono stati ridotti del 40%. La tendenza alla diminuzione degli stanziamenti è continuata nel ’94, anno in cui è stata istituita la commissione parlamentare d’inchiesta sull’attuazione della politica di cooperazione, con l’Italia crollata al ventesimo posto, su 21, in relazione al Pil (0,20%). Inevitabile è stato quindi il ridimensionamento degli impegni politici assunti con i governi dei Pvs. Da allora, tranne alcuni positivi segnali da parte di governi sensibili, i fondi per la cooperazione sono rimasti gravemente insufficienti, lasciando l’Italia quasi costantemente agli ultimi posti tra i paesi Dac.
Il resto è storia più recente, ma è bene ricordare che il lavoro di preparazione di un testo di legge di riforma organico della cooperazione allo sviluppo, conclusosi con la legge 125/2014, è iniziato proprio nel dicembre 1994 con la costituzione di un gruppo di lavoro informale nominato dal Ministro degli esteri a questo scopo. Se ne sentiva il bisogno allora, e si è continuato a sentirlo, stando ai tanti disegni di legge presentati e discussi negli anni ‘90 e 2000, ma ci sono voluti ben due decenni per giungere a una conclusione. Il passaggio dalla legge 38/1979 alla 49/1987 è invece avvenuto dopo solo otto anni.
Sei poi stato anche tra i protagonisti della nascita della nuova legge 125. Tra coloro che più hanno spinto, riflettuto e forgiato la riforma attuale. Quali le aspettative e quali i timori?
Il lavoro è stato veramente collegiale. Senza l’insieme di voci, di idee, di proposte e soprattutto senza la volontà e la tenacia di molti – nel Mae, in Parlamento, nelle Ong, nelle istituzioni pubbliche e private interessate – probabilmente non si sarebbe giunti all’approvazione della legge. Le Ong hanno certamente avuto un ruolo primario nel dibattito e nel sostegno ai gruppi parlamentari. E ciò anche sull’onda del lavoro fatto dal ministro Riccardi con il Forum di Milano nel 2012 e dai dieci gruppi di lavoro preparatori che hanno coinvolto per mesi decine di rappresentanti delle diverse realtà interessate, pubbliche e private, profit e non profit. Ci sono anche stati gruppi informali di riflessione e proposta, anch’essi promossi dalle Ong e aperti a più soggetti. Aver trovato parlamentari competenti e decisi a chiudere questo ventennale cammino verso la nuova legge, migliorando il ddl presentato dal Governo, ha facilitato e ha reso possibile la valorizzazione dell’ampio bagaglio di elaborazioni. La legge 125 è davvero un frutto collettivo. E ciò significa che la materia ha ripreso ad interessare e che molti soggetti intendono esserne partecipi.
L’aspettativa è che la legge venga attuata interamente e integralmente. Senza timori e senza ancoraggi al passato, anche se occorre farne tesoro. La Diplomazia dovrà essere valorizzata nella sua funzione politico-diplomatica di cui c’è immenso bisogno e l’Agenzia dovrà avere il suo spazio di ampia autonomia che la legge le assegna. Lo Statuto dovrà essere in tutto coerente con la lettera della legge e con lo spirito che ha guidato la volontà del legislatore. Molto dipenderà dalla scelta del direttore. Oltre all’autorevolezza, competenza, esperienza e professionalità acquisita nella cooperazione allo sviluppo e nei rapporti internazionali, dovrà mostrare capacità di relazioni umane, di entrare in sintonia con i partner nei paesi di intervento per realizzare un comune e duraturo cammino di sviluppo, anche a reciproco beneficio, di attrarre sempre maggiori risorse europee e internazionali grazie alla qualità dei risultati ottenuti. Il primo direttore darà l’impronta all’Agenzia e ne fisserà il carattere distintivo. Il ministro degli Esteri e il presidente del Consiglio dovranno riuscire a farsi guidare da un unico criterio di scelta: il migliore tra i candidati.
Rimangono nella legge alcuni punti che richiedono maggiore chiarezza. Ne segnalo due, in particolare. Il primo riguarda l’inserimento delle imprese profit tra i soggetti del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, su cui abbiamo pienamente concordato, superando diffidenze del passato. L’impresa può infatti creare occupazione, nuova impresa, benessere e sviluppo nelle realtà e comunità in cui è chiamata ad operare. L’obiettivo non può però essere il sostegno all’internazionalizzazione e agli investimenti esteri, come il mondo imprenditoriale italiano sembrerebbe auspicare. Essi devono essere favoriti, certo, ma non con i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo e alla lotta alla povertà che richiedono, anzi, forme di integrazione addizionale da parte delle stesse imprese. Per essere soggetto di cooperazione l’impresa dovrà identificarsi con le finalità della legge e, come precisa l’articolo 23, agire ‘con modalità conformi ai princìpi’ in essa indicati, aderire ‘agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali’, rispettare ‘le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali’. Le linee guida Ocse per le imprese che operano a livello internazionale rappresentano un valido strumento per attuare e verificare l’attuazione di tali principi. C’è da sperare che vengano adottati.
La seconda riguarda il vice Ministro. L’articolo 11 della legge stabilisce che “Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale … conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro”. Il Parlamento, fin dalla scorsa legislatura che ha determinato le scelte riprese poi dal ddl governativo, ha preso in considerazione due posizioni altrettanto valide: un Ministro indipendente dal ministero degli Esteri oppure un vice Ministro, espressamente dedicato, all’interno degli Esteri. La seconda opzione è stata scelta con la chiara ed inequivocabile intenzione di dare alla cooperazione allo sviluppo uno specifico e autorevole riferimento politico, non confuso con il Ministro, anche se ovviamente sotto la sua responsabilità politica. Il vice Ministro delegato voluto dalla legge 125 si avvicina molto a quanto stabilito da alcuni ordinamenti europei che prevedono, all’interno del ministero degli Esteri, un Ministro della cooperazione o un Ministro junior con piena competenza sulla materia. Non mi sembra che si stia andando verso una simile forte delega al vice Ministro e le resistenze non stanno certo attuando la legge e l’indubbia volontà del Parlamento.
Negli ultimi anni spesso hai sottolineato un cambiamento nella cooperazione allo sviluppo. Nella tua esperienza quanto è cambiato il sud del mondo?
Mi sembra che nella cooperazione allo sviluppo si stia riscoprendo il vero valore della solidarietà umana, non più intesa come donazione al povero del superfluo del ricco, ma come relazione, fiducia, rispetto, riconoscimento dell’alterità e dei suoi valori, rapporto di giustizia, di aiuto e al contempo di interesse reciproco, per il bene e la crescita comune e per la pacifica convivenza. Non si può più mirare ad un nostro vantaggio o interesse se non considerando, congiuntamente, i vantaggi e gli interessi dei nostri interlocutori, alla nostra sicurezza se non insieme all’altrui sicurezza, a un percorso di crescita e sviluppo senza impegnarsi a non recare danno ad altri a livello ambientale, economico, finanziario.
Rispetto anche solo a dieci anni fa il mondo è molto cambiato. La mondializzazione favorisce i contatti, la reciproca conoscenza e il dialogo tra persone di paesi e culture diverse, aprendo a visioni politiche nuove, a nuovi valori identitari, rendendo visibili e protagoniste comunità e persone rimaste ai margini. Le comunicazioni, gli scambi, i media e i social media avvicinano ma al tempo stesso allontanano, quando difendono identità enfatizzando distinzioni, rifiutando e combattendo le diversità. E’ anche in atto un cambiamento di mentalità, irreversibile a mio avviso, che porta ad aspirare al pieno godimento dei diritti, contro ogni disparità, e che influisce sui rapporti internazionali e sulla possibilità di convivenza pacifica. Nonostante gli innegabili progressi, rimangono immutate le disfunzioni del sistema economico e gli squilibri che ne conseguono. In Africa per esempio la media di crescita del Pil è ormai intorno al 5% annuo, ma rimane una diffusa povertà con sacche di miseria che sono rimaste le stesse che vedevamo trenta, quarant’anni fa, anche se in quei contesti è arrivato il telefonino.
Come succede ormai anche in Italia e nei paesi più ricchi, povertà e disparità continuano ad esistere e stanno tendenzialmente crescendo nel mondo, troppo spesso accompagnate da corruzione, illegalità, violazione dei diritti umani, distorsione degli aiuti, riduzione delle protezioni sociali, deboli modelli culturali. Si ha fortunatamente una diffusa consapevolezza di tutto ciò e del potenziale esplosivo che rappresenta. Anche per questo la cooperazione allo sviluppo deve essere intesa, sempre di più, come relazione, partnership a pari dignità, per riuscire ad affrontare i problemi con una visione nuova, di maggiore equità, giustizia, rispetto dei diritti umani, tutela dell’ambiente, con un’azione congiunta che duri nel tempo, trasparente e coerente con queste finalità.
Molti paesi sono chiamati a rafforzare sistemi di governance democratici, aperti alla circolazione delle idee e alla partecipazione dei cittadini, e ad essere più determinati sull’equità fiscale e la lotta alla corruzione. Dal canto suo l’Europa è chiamata ad un salto qualitativo nelle relazioni internazionali, in particolare con i paesi africani, mediterranei e mediorientali, che sappia guardare con lungimiranza al futuro per contribuire, insieme, ad orientarlo nella direzione dello sviluppo e della pace. Ma è chiamata anche ad un salto quantitativo, attuando l’impegno, preso decenni fa dalla comunità internazionale, di destinare almeno lo 0,7% del Pil, ai programmi di cooperazione per lo sviluppo.
Quanto invece sono cambiati i volontari, i cooperanti e le loro motivazioni?
Sarebbe un capitolo che merita ampio sviluppo. Mi limito ad evidenziare che in molti operatori e operatrici formati dalle Ong o che comunque partecipano alle loro iniziative di cooperazione esiste una forte tensione alla qualità e all’efficacia degli interventi, al coinvolgimento attivo dei partner e del personale locale, ai risultati e alla loro verifica. C’è la presa di coscienza che la spinta solidaristica e la dedizione, pur essenziali e che non devono mai mancare, non possano bastare. Ad esse vanno sempre affiancate preparazione e professionalità insieme ad umiltà e disponibilità all’apprendimento, conoscenza della realtà e delle dinamiche sociali, politiche e religiose dei contesti in cui si interviene, capacità di discernimento, disposizione alla relazione e all’ascolto, apertura a partenariati profondi e duraturi. Cooperazione è partnership: tra parti che apportano il meglio di sé per realizzare un comune cammino e comuni obiettivi. C’è ancora del cammino da fare, ma questa è a mio avviso la via per continuare a dare senso alla presenza di volontari e cooperanti, all’incontro tra persone e al lavoro svolto insieme, su cui le Ong credono debba basarsi il proprio modello di cooperazione.
Migrazioni e cooperazione. Una delle nuove frontiere su cui hai lavorato e su cui continui a impegnarti. Un tema su cui il nostro Paese è in prima linea. Cosa ti aspetti dalla cooperazione italiana ed europea in questo campo?
L’Italia è in prima linea nel Mediterraneo centrale. Ma le vie di ingresso in Europa, a sud e ad est, sono anche altre e coinvolgono Stati altrettanto in prima linea. Mi sembra che il nostro paese non sia ancora uscito dall’atteggiamento prevalentemente lamentoso, mentre occorrerebbe costruire ed assumere una vera strategia per la gestione, anche a lunga scadenza, dei flussi migratori. Giustamente si rimprovera all’Ue di non avere una strategia e una politica comune che sappia leggere e adeguarsi ai grandi cambiamenti, valutare i rischi che comportano, nella fedeltà ai propri valori di umanità, solidarietà, centralità della persona umana. Ma il nostro paese deve dimostrare a sua volta di agire con una politica e una strategia definite e con una larga condivisione a livello nazionale.
Da un lato, è doveroso salvare le vite umane, come si sta facendo in modo ammirevole, e accogliere con rispetto e dignità chi ha diritto all’accoglienza, anche aggiornando le regole quando necessario e accelerando le relative pratiche. Penso in particolare ai richiedenti protezione internazionale o umanitaria, a quanti sono ammessi a svolgere attività lavorative o di studio, ma anche ai parenti che intendono ricongiungersi per mantenere l’unità familiare. Dall’altro è a mio avviso indispensabile che, una volta aggiornate e definite le regole sugli ingressi regolari (oggi esageratamente limitati, favorendo quindi l’irregolarità), esse siano rispettate e fatte rispettare. In nessun paese si può rimanere e soggiornare al di fuori delle regole in vigore, se non vivendo nell’illegalità e quindi soggetti all’immediata espulsione nei termini previsti dagli accordi internazionali. Il criterio di umanità non deve mai mancare e in alcuni casi deve anche poter superare quello della legalità, ma non in modo improvvisato, disordinato, provocato da continui approcci emergenziali, come spesso è avvenuto in Italia nei recenti anni.
I 232 milioni di migranti censiti nel mondo nel 2013 sono destinati ad aumentare a causa dei molteplici fattori che causano l’emigrazione, a partire dalle gravi disuguaglianze, la povertà, l’incremento demografico, il crescente bisogno di lavoro, le calamità causate spesso dai cambiamenti climatici, le guerre e gli scontri armati, l’intolleranza e le persecuzioni, il desiderio delle nuove generazioni di muoversi per cercare nuove opportunità. Più di 2,5 miliardi di persone, un terzo dell’umanità, vivono con meno di 50 euro al mese e 800 milioni soffrono ancora la fame. Troppi, mentre la ricchezza di pochi aumenta a dismisura. Ben 350 milioni sono colpite da calamità e poco meno di 60 milioni sono fuggite da guerre e persecuzioni per cercare protezione e rifugio altrove. Questi dati corrispondono a persone con nome e cognome, come noi e con la nostra stessa dignità, ma spesso lo dimentichiamo. La chiusura delle frontiere, i muri, il cieco rifiuto non sono la soluzione, come è stato ormai ampiamente dimostrato. E disgustoso e molto rischioso per il futuro delle nostre società è l’atteggiamento di disprezzo fomentato da politici, media e opinion makers che fanno leva sulle paure e infiammano i sentimenti più bassi della gente.
I dati demografici parlano da soli. Nei prossimi trent’anni, i paesi più ricchi rimarranno stabili su 1,3 miliardi di persone in società che invecchiano (in Italia le nascite sono inferiori alle morti, con una denatalità preoccupante), mentre il resto del mondo continuerà a crescere portando la popolazione globale da 7,2 miliardi nel 2013 a 9,6 nel 2050. La popolazione africana passerà dagli attuali 1,1 miliardi a 2,4 con un’età media intorno ai 20 anni contro i 43 dell’UE e con 700 milioni di persone in età lavorativa. Sono le proiezioni, 2013, del Word Population Prospect dell’ONU, molto realistiche su periodi brevi come i prossimi trent’anni, che devono quindi essere tenute ben presenti dai decisori politici.
Schematizzando, la via da percorre è duplice ed è a mio avviso abbastanza chiara, anche se complessa e non semplice da realizzare. Da un lato quella della coerente e lungimirante gestione dei flussi migratori, possibilmente a valenza europea, aprendo canali legali per combattere il traffico di esseri umani. Ad essa si collega la successiva integrazione di quanti sono ammessi al soggiorno, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona, sapendo che una vera integrazione può avvenire solo se da parte nostra c’è piena coscienza e condivisione delle nostre identità e dei nostri valori si basa la proposta integrativa. Dall’altro lato quella dei rapporti di cooperazione, a partire dai paesi di provenienza e di transito, per il rafforzamento delle istituzioni e della governance e per uno sviluppo umano e sostenibile; e quella dell’azione politica, nazionale, europea e internazionale, per cercare di mettere fine ai conflitti e alle persecuzioni che provocano esodi di persone alla ricerca di protezione. Finora non sembra che in Italia si stia procedendo in questa direzione, né che a livello europeo e mondiale si vogliano affrontare le cause che provocano la migrazione, intervenendo con maggiore decisione e impegno sui fattori della povertà, del sottosviluppo e sui loro effetti, e agendo con lungimirante intelligenza politica per prevenire i conflitti e risolvere quelli in atto.
Limitandoci alla cooperazione allo sviluppo, se l’Africa non riuscisse ad offrire nuove opportunità di lavoro nei prossimi decenni, la migrazione di decine, forse centinaia di milioni di persone verso paesi africani economicamente più forti o verso l’Europa sarà inevitabile. Creare occupazione in Africa diventa un’assoluta priorità. Per farlo, la cooperazione allo sviluppo può assumere un ruolo decisivo, rafforzando la dimensione imprenditoriale, possibilmente in coordinamento con l’azione svolta dalle Ong e organizzazioni non profit, con investimenti pubblici e privati, al fine di creare impresa, occupazione, partecipazione e sviluppo diffuso. È una sfida che il settore privato italiano, ad iniziare da quello cooperativo, dovrà riuscire a cogliere.
Molti immigrati stanno dimostrando che non aspettano le incerte decisioni internazionali o governative per agire come promotori di sviluppo nei propri paesi. Con le rimesse e altri aiuti inviati alle famiglie alleviano la povertà, avviano attività che accrescono i commerci locali e l’occupazione, con le conoscenze e competenze acquisite stimolano l’innovazione e rafforzano la presa di coscienza dei diritti umani, del senso di cittadinanza e della partecipazione, contribuiscono al superamento delle vulnerabilità causate dalle crisi climatiche ed economiche. In questo senso gli immigrati possono, a pieno titolo, essere definiti attori di sviluppo. Come quelli che, dopo anni di esilio e protezione internazionale, ritornano per ricostruire il proprio paese alla fine del conflitto o della persecuzione.
Stiamo purtroppo sottovalutando la risorsa rappresentata dal transnazionalismo degli immigrati, in particolare di quelli più radicati nella società italiana e che hanno dimostrato interesse allo sviluppo del paese di origine. La loro capacità di essere qui e lì è un grande valore aggiunto e potrebbe diventare l’occasione per un’azione transnazionale dei territori, con l’avvio di partenariati tra le regioni di residenza, qui in Italia, e le regioni di provenienza. Tali partenariati dovrebbero a mio avviso aprirsi all’intera dimensione territoriale e coinvolgere ogni attore potenzialmente interessato e in ogni ambito possibile: sociale, culturale, economico, commerciale, istituzionale. Se in una regione è fortemente presente e radicata, per esempio, una comunità senegalese (o tunisina o egiziana o nigeriana o altra) che negli anni ha mantenuto rapporti con la terra di origine, un’ampia cooperazione tra le due regioni, qui e lì, non è solo possibile ma è anche una reciproca opportunità.
Anche il Consiglio europeo di dicembre 2014 si è mosso per la prima volta in questa direzione. Ha infatti approvato conclusioni sul nesso migrazione e sviluppo, sottolineando l’importanza della valorizzazione dei migranti e delle loro rimesse a fini produttivi e della creazione di partenariati che includano la diaspora nella pianificazione degli interventi di cooperazione. Tutto però si lega: una buona cooperazione, italiana ed europea, con i paesi di provenienza implica una buona accoglienza e integrazione di chi è ammesso a soggiornare nei nostri paesi.