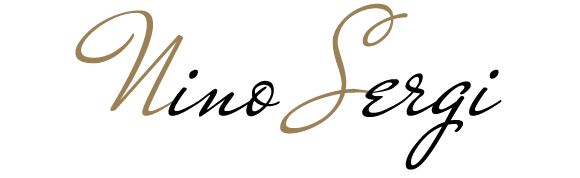Sono ormai passati 300 giorni dall’arresto di Alberto Trentini, riassumibili in due parole: silenzio angosciante. Il silenzio è stato rotto solo grazie agli appelli incessanti della madre Armanda Colusso, aggrappata disperatamente alle due telefonate in cui ha potuto sentire per pochi secondi la voce del figlio, e alle tante iniziative coordinate dalla rete “Alberto Trentini Libero” o promosse da associazioni, personalità e cittadini, compresa una petizione pubblica che ha ben superato le 100.000 firme, e grazie a un’informazione inizialmente scarsa ma oggi via via più attenta. Da parte governativa, solo poche dichiarazioni, quasi a colmare con imbarazzo un silenzio prolungato.
Negli anni, mi è capitato di seguire da vicino, in Paesi difficili, talvolta privi di riferimenti istituzionali credibili, alcuni sequestri di cooperanti di organizzazioni della società civile (Osc) impegnati in attività umanitarie e solidali. Si è trattato di sequestri a scopo estorsivo, per la cui soluzione era necessario cercare con fiuto e pazienza una controparte affidabile, o attendere un segnale che permettesse di avviare il contatto, pretendendo innanzitutto la prova che gli ostaggi fossero in vita. In quei casi, si ritenne indispensabile il totale silenzio stampa – fatte salve le informazioni diffuse a livello istituzionale o dall’Osc – poiché l’informazione può diventare uno strumento che favorisce, e non poco, i rapitori. Altrettanto indispensabile fu il rapporto stretto e sinergico – pur senza confusione dei ruoli – con le istituzioni italiane competenti, fondato su uno spirito di reciproca fiducia.
Il sequestro di Alberto Trentini, avvenuto il 15 novembre 2024, è di diversa natura, con una dimensione politica difficilmente interpretabile. Il successivo arresto e il totale isolamento in carcere non sono mai stati motivati né è stata mai formalizzata alcuna accusa. È stato affidato alle autorità della Direzione generale del controspionaggio militare, con destinazione finale Caracas. In questo caso, il silenzio richiesto può riguardare solo i passi seguiti nella ricerca di eventuali canali di trattativa e le fasi successive, che devono rimanere riservati per potere funzionare. Mentre deve continuare la pressione comunicativa perché non si perda tempo. Diverso invece è il rapporto – tramite l’Unità di Crisi della Farnesina – tra le istituzioni governative e la famiglia Trentini, che dovrebbe rimanere sempre aperto (e forse lo è già, data l’attenzione dell’Unità di Crisi), pur nel doveroso riserbo.
Alberto era arrivato in Venezuela un mese prima, con la Ong Humanity & Inclusion (già Handicap International), premio Nobel per la pace 1997. Ma la sua esperienza nella cooperazione internazionale è di tutto rilievo. Era stato in Bosnia-Erzegovina, Libano, Etiopia, Nepal, Perù, Paraguay, Ecuador, Colombia, alternando impegni con la Cooperazione italiana, Danish Refugee Council e altre Osc quali Cefa, Coopi e Focsiv. Con quest’ultima ha iniziato il suo percorso nel 2006, in servizio civile nella città ecuadoriana di Esmeraldas.
La situazione del Venezuela rende tutto molto difficile: il governo italiano e, più in generale, i Paesi occidentali non hanno riconosciuto l’elezione di Nicolas Maduro, e l’attuale tensione militare con gli USA sta assumendo un tono minaccioso, con i cacciatorpedinieri di Trump al largo delle coste venezuelane. Con gli Stati Uniti il confronto non è però del tutto chiuso. Nei mesi scorsi Maduro ha liberato diversi cittadini americani, in parte grazie a incontri con emissari di Washington e a scambi triangolari attraverso El Salvador. Diplomazia e forza muscolare si intrecciano in un equilibrio precario e rischioso.
Inoltre, il Venezuela non è del tutto isolato. Maduro coltiva relazioni con Cuba, Nicaragua e Bolivia e legami sempre più stretti con Russia, Cina e Iran. Anche tra Venezuela e Turchia continuano relazioni economiche e politiche. L’Italia, d’altro canto, ha buoni rapporti di cooperazione con Cuba (all’Avana l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo mantiene una sede con una ventina di addetti) e le relazioni tra Italia e Turchia sono complessivamente positive, non esenti da sfide ma con rapporti economici e commerciali stabili e molto solidi.
L’invio a Caracas dell’Ambasciatore Luigi Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, è indubbiamente un segnale importante, ma probabilmente questa mossa è stata concepita soprattutto per mostrare all’opinione pubblica italiana che il Governo si stava muovendo. Con un paese come il Venezuela – i cui esiti elettorali non sono stati riconosciuti dal governo italiano, che ha mantenuto una posizione sospesa riguardo al riconoscimento di specifiche figure governative, a partire dal presidente Maduro – una simile missione diplomatica avrebbe richiesto tempi di preparazione che, in questa occasione, sembrano non essere stati rispettati.
La via intrapresa potrebbe però rivelarsi quella giusta. Vignali è un diplomatico di grande esperienza, capace di valutare fin dove e come spingersi e di scegliere con lucidità direzioni e interlocutori. La speranza è che possa contare su un’adeguata libertà di movimento e su un massimo coordinamento operativo con gli apparati delle Stato indispensabili per il buon esito della missione. Che dovrà probabilmente molto contare sulla mediazione di Paesi da un lato amici del Venezuela e dall’altro amici nostri: Cuba, in primis, ma anche Turchia. Buona diplomazia, quindi, ed esercizio di mediazione grazie ai buoni rapporti bilaterali dell’Italia.
Intanto, media, società civile, influencer politici e culturali, cittadini sensibili di ogni ordine e grado, continuino a farsi sentire e a esercitare pressione. Trecento giorni sono davvero troppi, e l’Italia finora ha dato l’impressione di muoversi male e tardi. Speriamo che sia soltanto un’impressione. È ora che Alberto ritorni a casa.
Pubblicato su VITA NON PROFIT